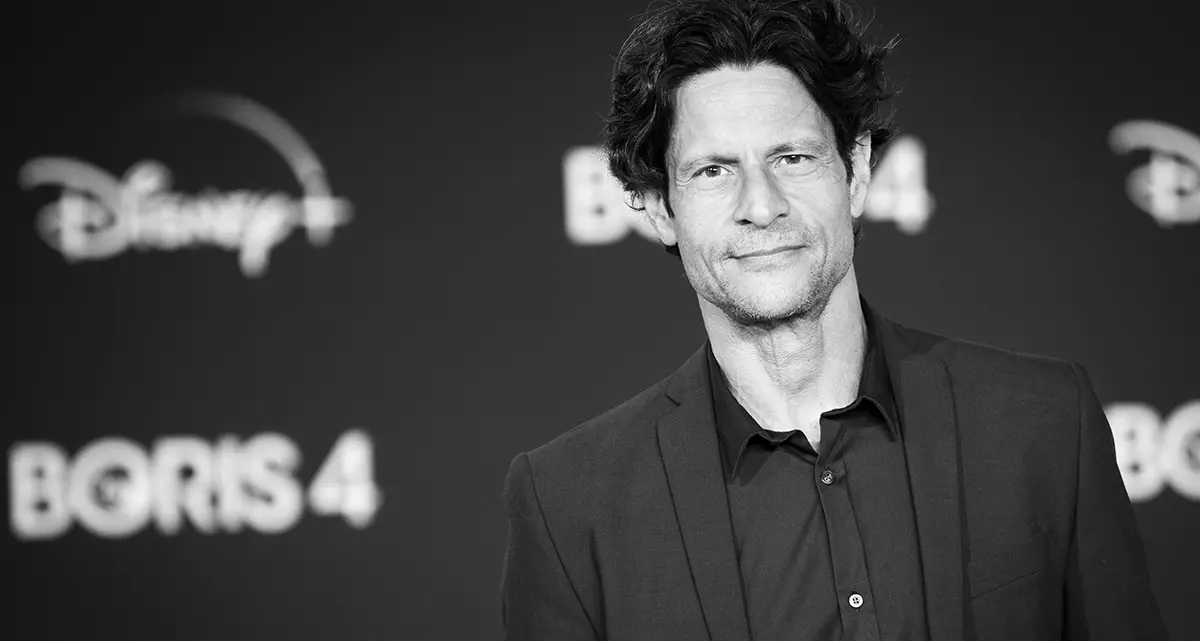PHOTO
James Gray (foto di Karen Di Paola)
La sua opera prima, Little Odessa, James Gray l’ha girata a soli 25 anni: come ci è riuscito? “Un produttore aveva notato un film che avevo realizzato al college. Mi propose delle sceneggiature, le rifiutai tutte. Pensavo di poter fare di meglio, di essere il migliore. E invece non sapevo niente. Ero uno stupido, arrogante. Ed ero depresso perché era appena morta mia mamma. Al primo montaggio, mi cadde il mondo addosso: era la cosa peggiore che avessi mai visto, da allora il mio ego non si è più ripreso. L’ego ti ammazza”.
È un James Gray in gran forma, quello che si è donato al pubblico della Festa del Cinema di Roma. È uno dei protagonisti di Absolute Beginners, la sezione del festival in cui i registi ripercorrono le loro prime esperienze dietro la macchina da presa. E, nel suo caso, è anche l’occasione per presentare l’ultimo lavoro, Armageddon Time, già in concorso all’ultimo Festival di Cannes e nel palinsesto di Alice nella città in coproduzione con la Festa.
“C’era appena stato l’exploit di Quentin Tarantino con Le iene – ricorda Gray – quindi prendemmo Tim Roth che era molto popolare. È diventato un mio amico, anche se non ci frequentiamo spesso, così come lo era il compianto Maximilian Schell. Mi piace il dialogo con gli attori: ho avuto la fortuna di conoscere gli ultimi grandi insegnanti dell’Actors Studio che mi hanno aiutato a capire cosa serve a un interprete”.
E da Little Odessa qualcosa è cambiato: “Ho deciso di essere onesto, voglio che i miei film rivelino me stesso e la storia della mia famiglia. Ma sono trent’anni che non lo rivedo: ci ho provato una volta e ho notato solo errori”. Tra il primo e il secondo film sono trascorsi sei anni, tra il secondo e il terzo sette: perché? “Non volevo fare cose che non mi interessavano. Ho avuto problemi a girare un film con grande budget, Harvey Weinstein ha fatto tutto ciò che poteva per impedirmi di lavorare. Dopo il terzo film, I padroni della notte, sono riuscito a essere più costante”.
Fil rouge della sua opera è il crime: “Ma non lo considero un genere. Mio padre aveva problemi con la legge, la polizia è stata molto presente nella mia vita: per me il crime è un tentativo di rappresentare uno spaccato del mondo. Ma ciò che mi interessa davvero è sovvertire, decostruire, interpretare i generi”. Ad Astra, il suo precedente film, ribaltava il genere della fantascienza? “L’intenzione era quella, pensavo a 2001: Odissea nello spazio. Ma è stato un’esperienza frustrante. Non ho avuto il final cut: la mia versione era più breve ma aveva più cose. E non c’era la voce narrante”.


Non nega la sensibilità europea: “Sono di New York, una città sospesa tra vecchio e nuovo continente. Abbiamo una cultura liberale diversa dagli altri stati, coltiviamo un rapporto diretto con la memoria delle migrazioni”. E punzecchia i colleghi: “I cineasti della mia generazione sembrano ignorare la Storia e la Politica, dimenticano che siamo il loro prodotto”. Tra i film che considera seminali nel suo percorso, Gray si lancia in una dichiarazione d’amore al cinema italiano: “Non lo faccio perché sono qui. Potrei citare a memoria Rocco e i suoi fratelli, uno dei miei film preferiti: mi ha segnato la vita. Sono d’accordo con il mio amico Scorsese quando dice che il cinema italiano è lo zenit dell’arte. È stato grande perché sapeva unire il contesto storico e politico con le storie personali. E poi amo Fellini, Antonioni, Risi, Rosi, Pasolini, Scola, Bellocchio, Bava... E Lina Wertmüller: Pasqualino Settebellezze è l’unico film a dire che a volte è più dignitoso non sopravvivere”.
Senza dimenticare il cinema americano: “Mi sto specializzando nel cinema classico, non vedo serie televisive perché sono impegnato a vedere tutti i film del passato. Ho una passione per lo studio system hollywoodiano degli anni Quaranta: sono film politicamente spaventosi eppure emotivamente complessi, semplici ma non facili: Ford, Hawks, Hitchcock, Wyler e gli altri hanno capito che il lavoro era il modo per dialogare con se stessi, per identificarsi come autori”.
Armageddon Time rievoca la sua infanzia e non manca uno dei temi fondamentali del cinema di Gray: il rapporto con il padre. “È stato il legame più importante della mia vita, finché non sono diventato padre. A volte mi sono chiesto perché i miei genitori avessero fatto dei figli. Per intenderci, una volta chiesi a mio padre quale fu l’anno migliore della sua vita e mi rispose che fu il 1975. Io sono nato nel ’69, mio fratello nel ’76. Chiaro?”. Oggi è padre, e si illumina quando parla dei figli: “I bambini non sono innocenti, smettiamola con questa bugia. Un esempio è il mio più piccolo: mi ha giurato che non mi ucciderà mai”.
Quindi cosa vuol dire essere artisti? “Essere artisti fa schifo, siamo dei narcisisti, è una lotta continua. Ma non cambierai questa vita per nulla al mondo, perché sono pronto a lottare. Bisogna credere in ciò che si fa, per diventare migliori. Mi piace fare film perché mi sembra il modo più vicino per entrare nella coscienza altrui, come 8 ½ di Fellini. È la vita che mi sono scelto.”.