PHOTO
Daniele Vicari
Liquidare il cinema a forza di certificati di morte è un esercizio che trova da tempo impegnate le voci più diverse. E si tratta di un’attività così abituale, corale, che è anche tanto paga di se stessa al punto tale da eludere o liquidare alla svelta l’interrogazione su cosa effettivamente sia il cinema sia oggi. Né le sue dichiarazioni di morte sono un fatto nuovo: ciclicamente, con andamento pressoché decennale, si ripetono sin dalle sue origini.
È una delle osservazioni che innesca le riflessioni di Daniele Vicari nel suo libro Il cinema, l’immortale (Einaudi, pagg. 144, € 12,00). Che il cinema sia stato detto da subito “invenzione senza avvenire”, può allora voler dire, oggi, e a dispetto di quanti pretendono di conoscerne in anticipo il destino ultimo, che non ha avvenire che sia già scritto in anticipo, che non cessa di scriversi e mutare. Emerge questo soprattutto dal libro. Nel quale, lucidamente e con la passione dei curiosi che di fronte ai mutamenti non si spaventano aprioristicamente, ma tentano di sondare in cosa essi consistano, Vicari si interroga sulla configurazione attuale della settima arte.
Questione che la pandemia ha certo contribuito a rilanciare, e sulla quale occorre tornare senza però accodarsi comodamente all’orazione funebre per il cinema, ripetuta a oltranza più che discuterla e sviscerarla. A farlo, questa volta, è un regista, che anziché imbrigliare in un rigido quadro teorico l’interrogazione, sa invece sollecitarla, si misura con essa guardando a eventi e dati che del cinema segnalano sicuramente i mutamenti e non la morte.
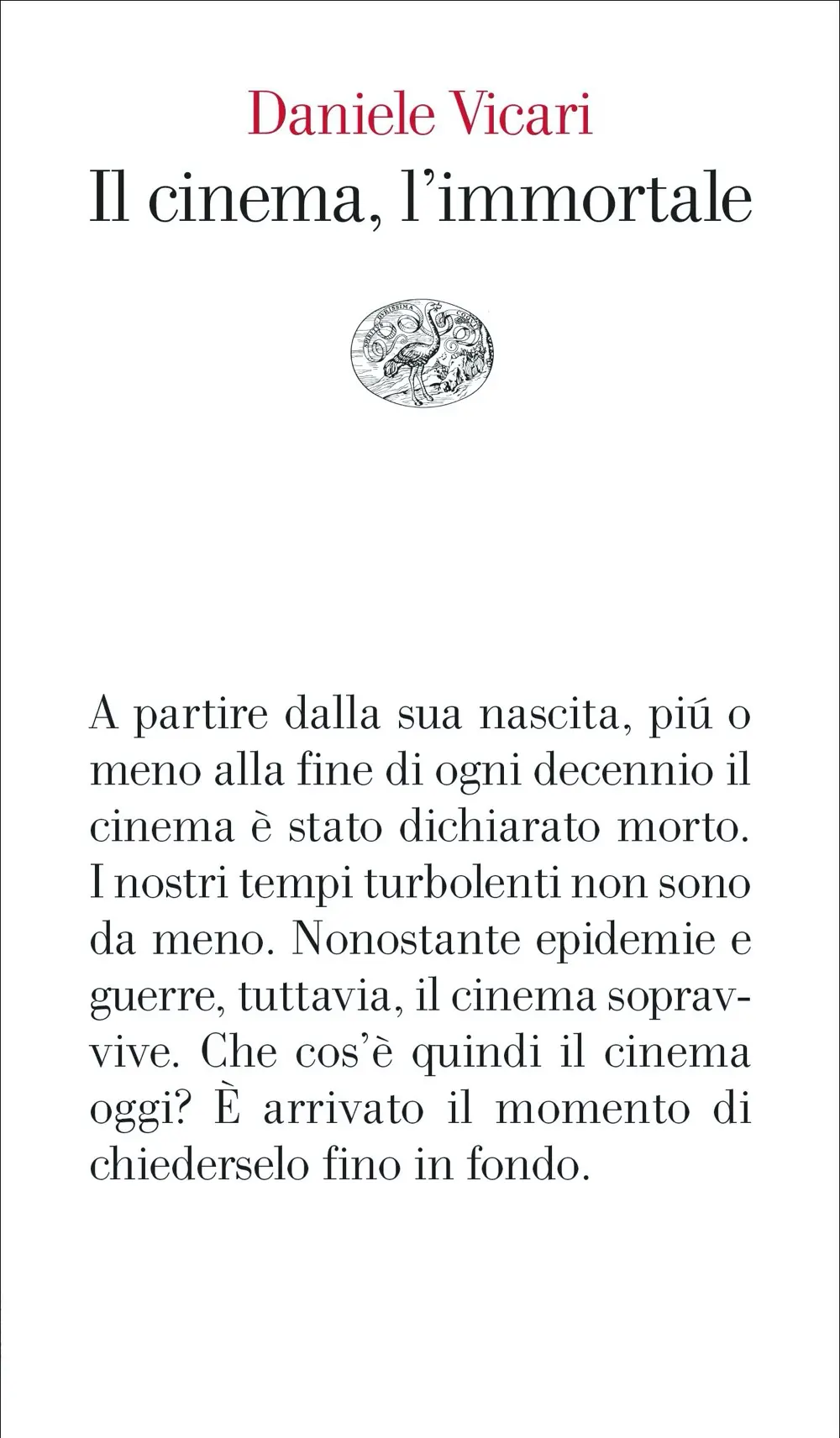
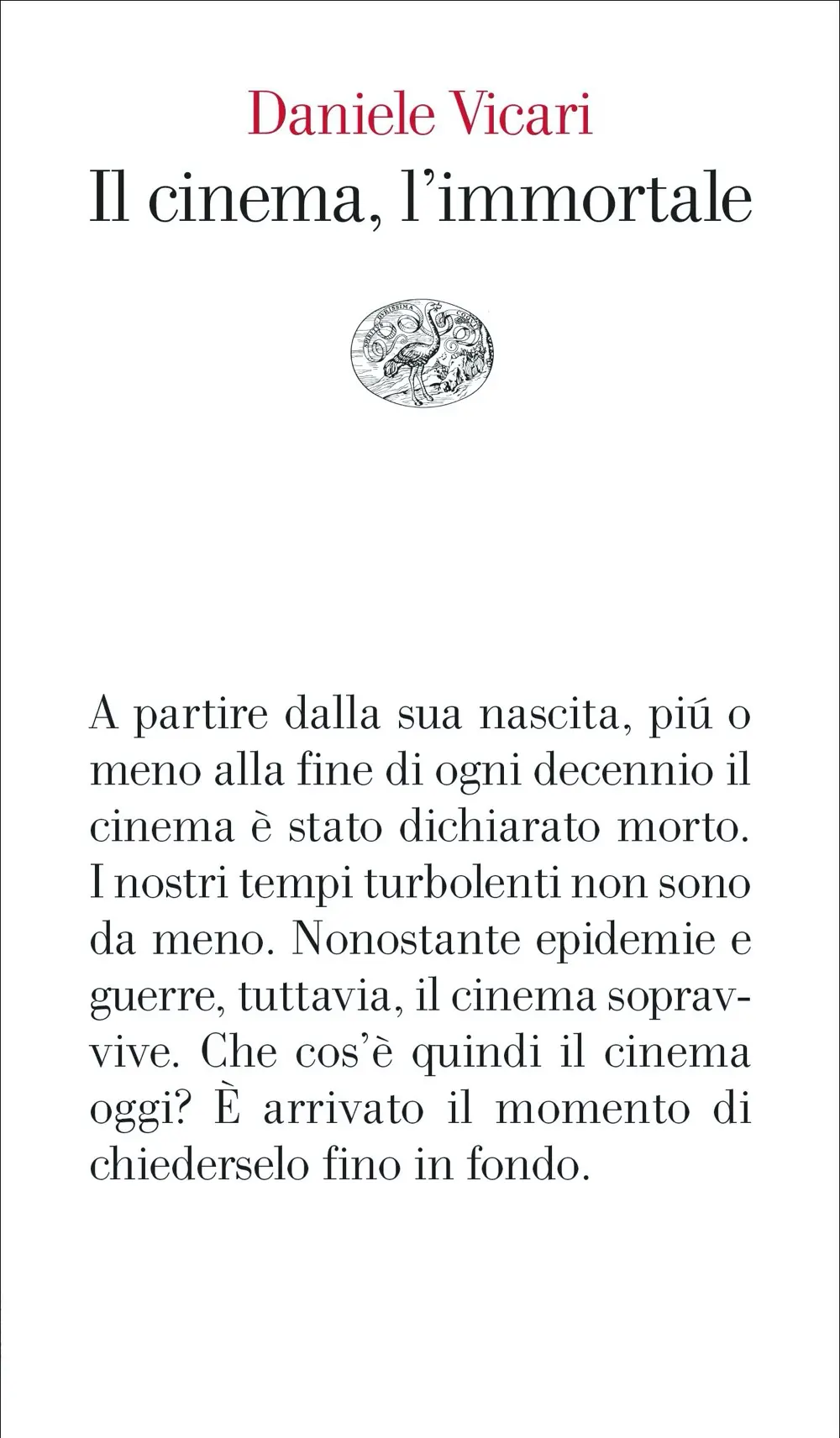
Il libro, pertanto, è giustamente fitto di domande, le solleva, individuando dei luoghi di riflessione a partire dai quali si può muovere per tentare una lettura dello stato attuale del cinema (e i suoi possibili futuri, non ancora scritti) ponendolo in dialogo serrato con la sua storia e i cambiamenti che l’hanno fatta.
Per esempio: se è vero che tutti “pratichiamo” l’audiovisivo, in quanto provvisti dei mezzi tecnologici per farlo, non necessariamente si è poi altrettanto capaci di scrivere e leggere quel linguaggio in maniere autenticamente creative, critiche, consapevoli. Donde la necessità di far corrispondere all’utilizzo massivo una profonda conoscenza del linguaggio stesso, analitica e strutturale, osserva Vicari.
Si tratta quindi di lavorare ancora, in modo più organico e deciso, sulla film literacy che negli ultimi anni i programmi delle politiche europee hanno incoraggiato, e che però deve ulteriormente incrementarsi per tenere il passo con la complessità crescente dello scenario mediale, tecnologico, sociale contemporaneo. La storia del cinema offre, in questo, un precedente particolarmente significativo, sia pure in un contesto storico, politico e culturale diverso.
È quella “alfabetizzazione” di massa al cinema cui già auspicava il lavoro di un Vertov, il suo progetto di “cinetizzazione” intrinsecamente pluralista, che avrebbe dovuto coinvolgere più gruppi di cineasti-operatori-montatori-attivisti sparsi in ogni dove. Il “dislocamento”, d’altra parte, interessa oggi (ma già da tempo) anche la stessa sede fisica del set, e la possibilità di realizzare un film “a distanza”, magari coi membri della troupe in luoghi diversi (come accaduto allo stesso Vicari per il suo film Il giorno e la notte, girato durante il lockdown), può non per forza minare pericolosamente la struttura produttiva del cinema, quanto la sua prassi.


Isabella Ragonese in Il giorno e la notte di Daniele Vicari
E addirittura incentivare altre forme di creatività, anche condividendo le competenze tra i vari reparti (per il suo film, il regista porta l’esempio di attori che all’occorrenza si sono fatti anche operatori). Al di là di questo, se uno degli argomenti che più spesso portano coloro che suonano le campane a morto per il cinema è la desertificazione delle sale – in parte aggravata dalla pandemia – non può darsi che essa segnali quanto il bisogno di film sia al fondo marginale, o inesistente?
Sta di fatto che, dati alla mano, Vicari evidenzia come il desiderio di cinema non sia affatto cancellato, considerando per esempio che la visione di film, in molti casi e proprio sulle piattaforme, ha superato quelle di altri oggetti e formati audiovisivi che il senso comune concepisce come rivali. In questo senso, i dati italiani sull’affluenza in sala post-lockdown, per quanto certo meno confortanti che in altri paesi europei, non autorizzerebbero comunque a parlare sbrigativamente di morte del cinema o del desiderio dello stesso.


Daniele Vicari e Michele Placido sul set di Orlando (credits: Dominique Houcmant e Jean François Ravagnan)
E forse neppure bastano a proclamare ancora una volta la fine delle sale stesse, per le quali Vicari sembra parlare piuttosto di una ridefinizione. Che deve essere soprattutto identitaria e che pertanto può legarsi a una scelta “forte” nella costruzione della programmazione e delle proposte, e che non riduca le sale a meri contenitori anonimi, generici, indifferenziati. Perché il bisogno di cinema è, ancora, e può trovare, per nutrirsi, forme insospettabili per il senso comune.
La ragazza che Vicari scorge nel corso d’un viaggio in treno, fissa da ore sullo schermo di uno smartphone, non sta interagendo su un social come è quasi automatico supporre, ma, guarda 2001 di Kubrick. Ha negli occhi e nelle orecchie qualcosa di più del solo suo dispositivo: è l’invenzione che non ha avvenire che sia già scritto, ma ancora da immaginare.
