PHOTO
Carl Theodor Dreyer (credits: Interview with Carl Theodor Dreyer, 1965)
Ero uno studente liceale e attorno al 1960 fu – con qualche arditezza – proiettato nel Seminario arcivescovile milanese Ordet, in danese “la parola”, uscito nel 1955 e premiato col Leone d’oro a Venezia. La narrazione era tesa e lenta al tempo stesso, capace di creare un effetto ipnotico e un’adesione affascinata nonostante la pellicola fosse in danese e solo sottotitolata. Indimenticabile era Johannes, lo studente di teologia, un folle (o un “idiota” dostoevskiano) di Cristo e della sua parola con la quale attuerà il miracolo della risurrezione della moglie del fratello ateo Mikkel, una scena che è stata considerata come una delle più emozionanti della storia del cinema.
Nacque, così, il mio amore ammirato per il regista Carl Theodor Dreyer, nato a Copenhagen nel 1889 e morto nel 1968, un autore proteso in un’incessante ricerca spirituale, sulla base della sua matrice luterana, votato a una catarsi assoluta anche a livello di linguaggio: si pensi che per un altro suo capolavoro tanto celebrato, La passione di Giovanna d’Arco (1928) egli aveva girato 85000 metri di pellicola per usarne solo 2200. Anzi, l’unico negativo fu bruciato in un incendio e si tentarono varie riedizioni, finchè quasi miracolosamente nel 1984 venne alla luce una copia del primo negativo all’interno di un ospedale psichiatrico norvegese, copia prestata dal regista al direttore dell’ente e non mai restituita.
Da allora ho cercato di inseguire – soprattutto nelle tarde ore notturne su qualche canale televisivo coraggioso o nelle riedizioni in videocassetta – l’intera e sobria produzione di quel genio. Penso all’onirico e inquietante Vampiro (1932), al potente Dies irae (1943), una parabola che non teme di intrecciare colpa, dolore, giudizio, superstizione, intolleranza e confessione, fino all’ultimo film, Gertrud con una riflessione sulla femminilità, come era già accaduto in altre sue opere. Certo è che spesso affiorava il male oscuro che incrinava la felicità, l’irruzione della menzogna e della colpa, il sacrificio espiatorio (penso ai Due esseri del 1944).
Ma il sogno di Dreyer, “artista-santo”, come lo definiva Fellini, la stella polare della sua vita non solo d’artista, e il desiderio supremo sempre frustrato erano stati la creazione di un film su Gesù: ed è con questo titolo, e con l’aggiunta esplicativa Il film di una vita, che la sempre raffinata editrice milanese Iperborea ha pubblicato, a cura di Marco Vanelli e con una preziosa postfazione di un importante critico come Goffredo Fofi, l’intera sceneggiatura del film irrealizzato (pp. 424). Che i Vangeli fossero per lui una sorta di sangue e di anima pulsante appariva già nel suo primo film del 1920 Pagine dal libro di Satana: la prima delle quattro incarnazioni-tentazioni diaboliche riguardava proprio il tradimento di Giuda attraverso la lusinga di un fariseo.
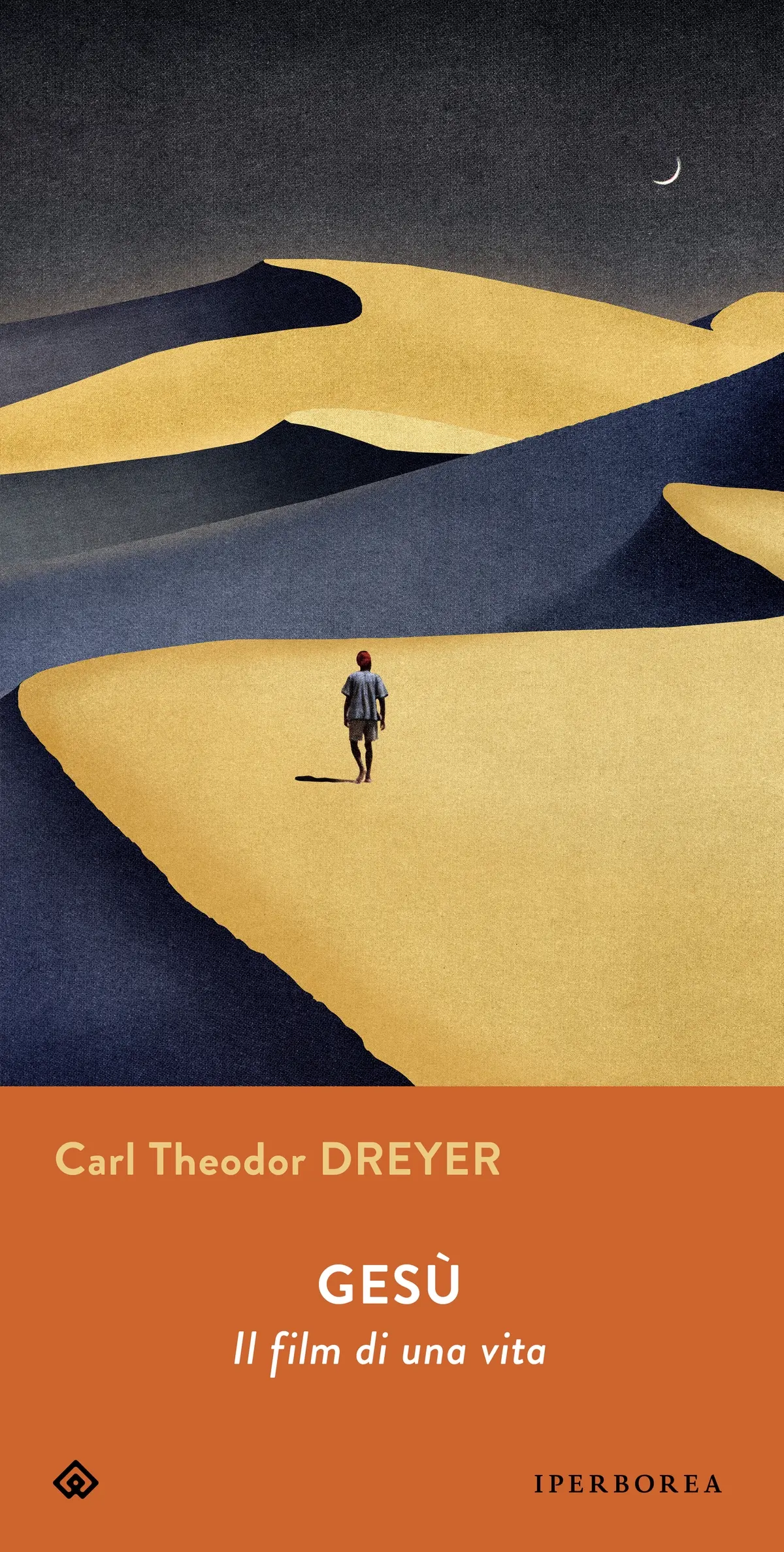
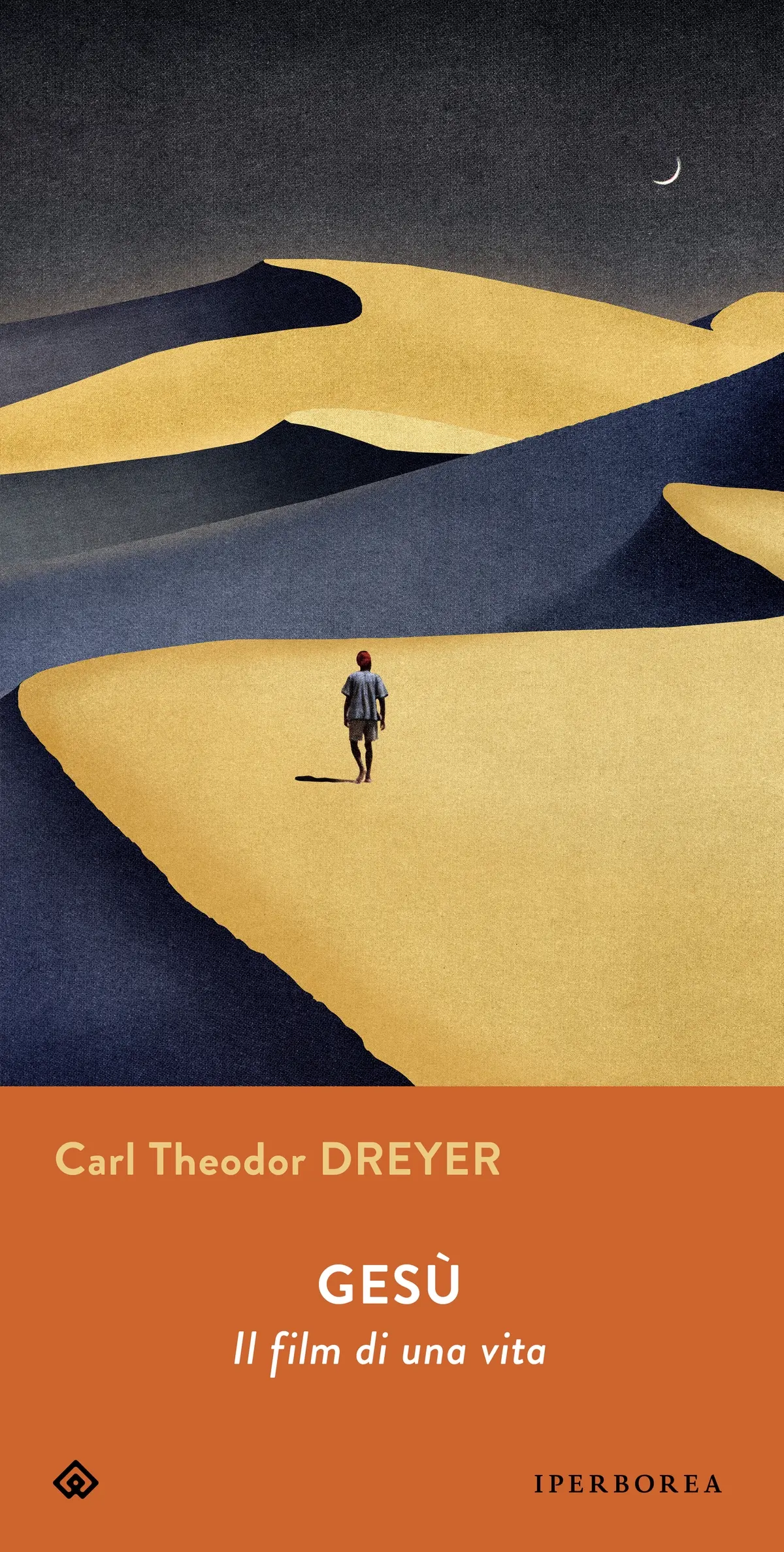
L’avventura vissuta dal testo di Gesù assomiglia a quella della pellicola della Giovanna d’Arco sopra citata, anche perché Dreyer inizia a pensarlo già con l’irrompere del nazismo negli anni Trenta e lo insegue approdando alle soglie della morte – dopo varie redazioni e vicissitudini – quando la Rai rivela il suo interesse al progetto. Siamo nel 1967, ma il 20 marzo 1968 il regista muore custodendo il film nella sua mente ove, come confessava in un’intervista, l’aveva girato più volte.
C’è un particolare che mi ha incuriosito, offerto dal curatore Vanelli. Alla Rai, prima di imbarcarsi nell’impresa, chiesero un parere all’allora professore Carlo Maria Martini del quale proprio in quell’anno 1967 io ero alunno di critica testuale biblica: la sceneggiatura reca ancor oggi i richiami laterali, i segni a matita e i punti interrogativi annotati dall’esegeta gesuita che sarebbe poi divenuto arcivescovo di Milano.
Come ricorda Fofi, «Pasolini si dedicò all’impresa del Vangelo secondo Matteo solo quando fu chiaro che Dreyer non sarebbe riuscito a realizzare il suo di Vangelo». Naturalmente, leggendo questa sceneggiatura si intuiscono anche le divaricazioni ancora prima delle consonanze. Comune è l’amore per una figura come quella di Cristo: «So chi era Gesù soltanto per ciò che ha detto e fatto. Se era o no il figlio di Dio – confessava Dreyer – nel senso letterale del termine, lo ignoro. Ma la figura di Gesù mi ha sempre affascinato». Da luterano, anche se non praticante, egli ferma però il racconto alla crocifissione, evitando la risurrezione e adottando soprattutto la dottrina espiatoria del sacrificio di Cristo per l’intera umanità, capitale nel pensiero del Riformatore.
Questo, però, non esclude l’adesione alla trascendenza gloriosa, come affiora nella narrazione dei miracoli nei quali il divino artiglia la storia e la trasfigura. Una storia che impedisce alla figura e al messaggio dell’amore di Cristo di decollare verso cieli mitici o mistici, ma si àncora alla realtà quotidiana, come fa comprendere l’incipit del film ove si citano le prime righe del celebre prologo di Giovanni, col Battista «che rende testimonianza della Luce, la Luce vera che era nel mondo, ma il mondo non la riconobbe». La dialettica storica vede il rifiuto, certo, dell’ebraismo di allora ma soprattutto la vera colpevolezza della morte di Cristo da parte dei romani, ammiccanti per Dreyer alla prepotenza nazista.
Il suggello al film è nella voce fuori campo finale che offre la chiave ermeneutica dell’opera: «Gesù muore, ma con la morte portò a termine l’opera iniziata in vita. Il suo corpo fu ucciso, ma il suo Spirito viveva. I suoi insegnamenti immortali portarono agli uomini di tutto il mondo la buona novella di amore e di carità pronunciata dagli antichi profeti ebrei».
