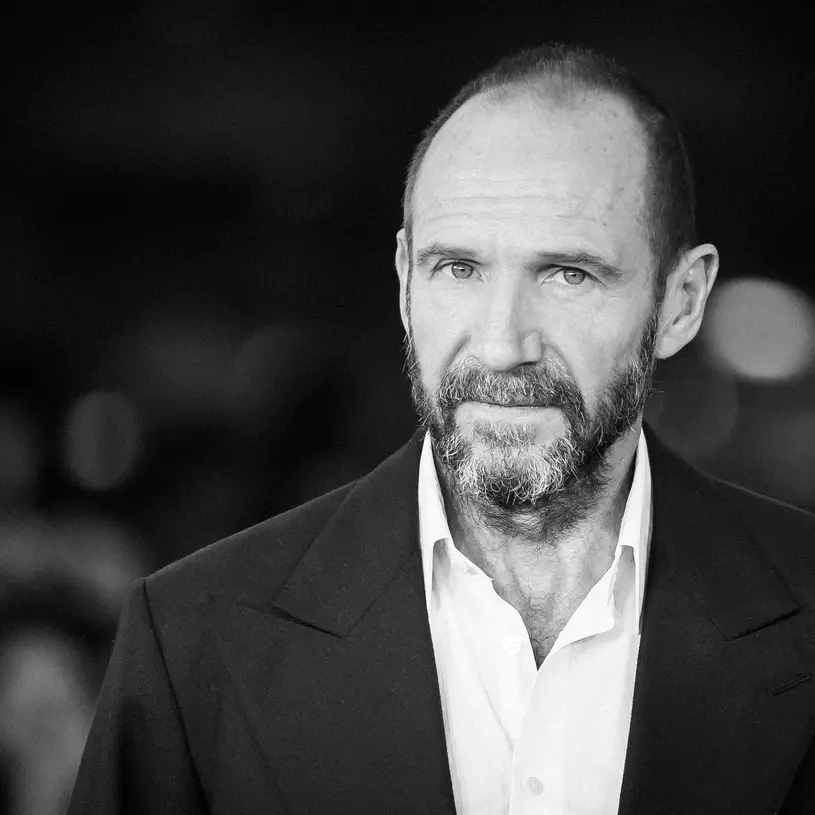PHOTO
Un prophete
C'è una costante affascinante nel cinema di Jacques Audiard. E' questa capacità dei protagonisti dei suoi film, sia maschi che femmine, di far diventare un handicap fisico, psicologico, comportamentale una leva su cui costruire una ricca risorsa futura.
Malik El Djebena (un travolgente Tahar Rahim al suo esordio come attore principale) è l'ultimo della trafila dei "deboli" corpi messi in scena da Audiard. Il ragazzo è condannato a sei anni di prigione, non sa né leggere né scrivere e al suo arrivo alla centrale di polizia pare un cagnetto spaurito. Viene come gettato in pasto alle non regole di un penitenziario che ha tutta l'aria di una banlieue in continuo fermento. La peggiore teppaglia assemblata in un unico luogo ermeticamente chiuso. Nessuno ambisce ad evadere, l'obiettivo è costruire un microsistema che riproduce quello violento e squilibrato che c'è fuori. Il gruppo più inserito e temuto nella galera, tra musulmani di ogni latitudine, è quello dei corsi, governato dell'anziano Cesar Luciani (un edipico Niels Arestrup). Non passa che qualche settimana e Malik per sopravvivere è costretto a far fuori un detenuto nordafricano che potrebbe testimoniare contro i corsi, pena, a sua volta, il proprio osso del collo. L'iniziazione alla vita del carcere è servita, con immediatezza, rudezza ed estrema fisicità.
Un prophete da qui in avanti è un fiume in piena di prepotenti dinamiche gangsteristiche, di naturale sanguinosa violenza tra uomini. Malik impara ad uccidere, si alfabetizza nella scuola del carcere, si droga, diventa amico di un altro carcerato malato di cancro e della sua famiglia. La presa del potere del ragazzo avverrà a scapito del vecchio corso rimasto isolato in cella (qui c'entra anche Sarkozy e un po' di politica). Audiard cuce insieme ritmo e spettacolarizzazione, disegna linee rette per le psicologie dei criminali e non si vieta incursioni mai gratuite nel grand guignol. La sua macchina da presa non ha bisogno di eccessivo movimento, basta aver davanti all'obiettivo la presenza potente di un balletto di facce da ceffi, sbirri corrotti, unghie lunghe e anelli da mafioso, lamette, pistole automatiche. Le sovraimpressioni con brevi frasi e/o nomi dei protagonisti provano a scostare in capitoletti una materia narrativa talmente compatta che due ore e mezza passano come niente. Il respiro di un gangster movie compresso tra le quattro mura spaziali di un carcere con sequenze da tenere a memoria. Quella investita da un pezzo hip-hop, in cui la mdp segue i frammenti ripetuti della preparazione del pasto tra cucina, corridoi, cortile, celle, uffici delle guardie, è semplicemente all'altezza di Quei bravi ragazzi.
Autocitazione: Malik rimane assordato per qualche minuto ripetendo quell'effetto di straniamento sensoriale vissuto da Carla/Emanuelle Devos, in Sulle mie labbra.