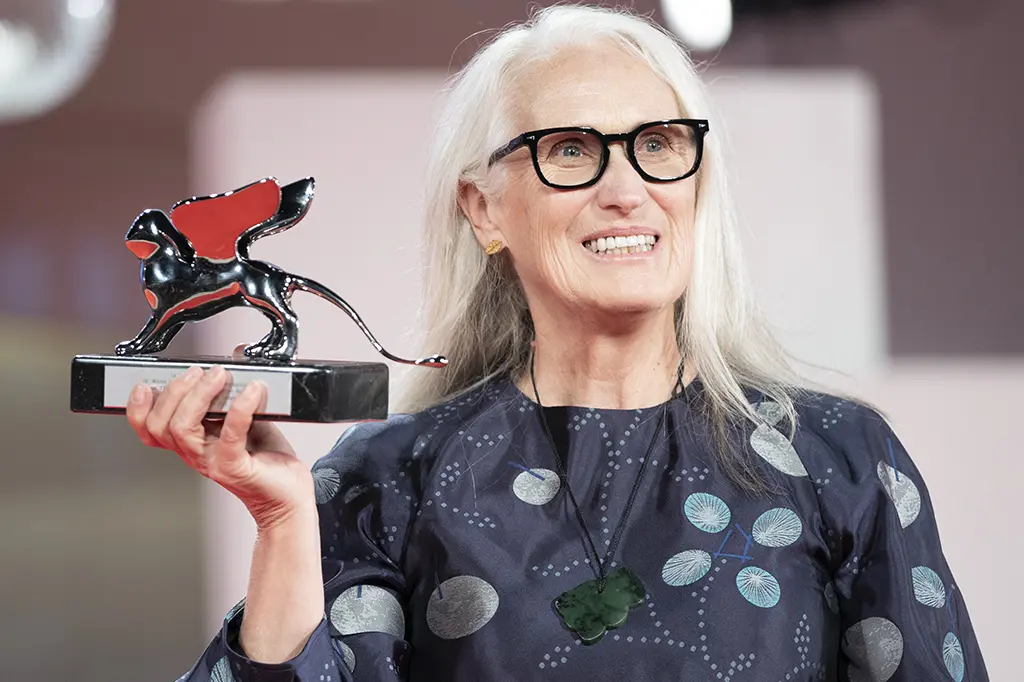PHOTO
La filmografia di Jane Campion, giunta a traguardi apicali nell’arco di pochi anni, è caratterizzata da una campitura tematica che verte sul potere costrittivo delle norme sociali e sulle sue implicazioni nell’interiorità dei personaggi, in primis quelli femminili. Le protagoniste dei suoi film sono giovani donne anticonformiste e ribelli, che vivono una scissione profonda dentro e fuori se stesse, afflitte da gravi distonie relazionali, in particolare negli ambiti più intimi della sessualità e degli affetti familiari. Per istinto e necessità, esse si scontrano con gli ideali di femminilità dominanti, e questa inadeguatezza le rende “difformi” agli occhi del loro ambiente di riferimento e le condanna alla riprovazione e all’esclusione sociale.
A questo cinema e al suo modo esemplare di indagare la qualità femminile nell’esperire il mondo sono dedicate le pagine che seguono, tese a ricostruire la pratica cinematografica della regista neozelandese alla luce del suo background formativo (gli studi di antropologia, belle arti e cinema) e di una molteplicità di influenze, riferimenti culturali ed esperienziali rintracciabili nell’analisi della sua opera: un patrimonio d’elezione che spazia dalla letteratura (le sorelle Brontë, Flannery O’Connor, Emily Dickinson, Marguerite Duras, Janet Frame, Henry James, Katherine Mansfield, Virginia Woolf, John Keats e George Eliot, tra gli altri) alle arti visive (Joseph Beuys, Frida Kahlo), dalla fotografia (la pioniera Julia Margaret Cameron, Diane Arbus, Cindy Sherman) alla musica (Michael Nyman, Wojciech Kilar, Mark Bradshaw) e al cinema stesso (Michelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci, Robert Bresson, Luis Buñuel, Francis Ford Coppola, Hal Hartley, John Huston, Jim Jarmusch, Akira Kurosawa, Spike Lee, David Lynch, Roman Polanski, Gus Van Sant, Martin Scorsese, Peter Weir e Lina Wertmüller).
Lungo l’arco di una carriera trentennale Campion ha perlustrato con finezza la sfera emozionale e la complessità del desiderio femminile nella cultura occidentale, dal Romanticismo alla contemporaneità, con un preciso discorso sulla fisicità della scrittura poetica e letteraria (si pensi a Un angelo alla mia tavola, Ritratto di signora, In the Cut, Bright Star), e con una descrizione psicologica dei personaggi che non è mai incline alle formule facili, come per esempio il cliché del binomio genio e follia.
Come inoltre è contro ogni schematismo e ideologismo il modo in cui la cineasta scandaglia i comportamenti dei suoi personaggi e i risvolti delle loro azioni, restia a etichettature à la page, prima fra tutte la catalogazione di “regista femminista” da lei sempre ritenuta limitante:
«Devo ammettere che per molto tempo ho ignorato il significato di questa parola. La cultura femminista si è diffusa come reazione agli stereotipi e alla prospettiva maschile dominante. Molte questioni devono essere ancora chiarite: la mia idea di cinema non può essere definita solo da questo argomento. Sono interessata alla vita nella sua interezza. Anche se la rappresentazione di un personaggio femminile ha un’impostazione femminista, è comunque un solo aspetto del mio approccio».


L’«impostazione femminista», citata dalla stessa Campion in merito ai suoi personaggi femminili, è in linea con l’epigrammatica definizione di Rosi Braidotti della teoria femminista, che «è la critica del potere nel, e in quanto, discorso, è lo sforzo attivo per creare nuovi modi di pensare; è l’impegnarsi in un processo per imparare a pensare in modo diverso» (R. Braidotti, Soggetto nomade. Femminismo e crisi della modernità, a cura di A.M. Crispino, Donzelli, Roma 1995, p. 53). Sulla sintonia del cinema campioniano con l’elaborazione femminista, si rinvia al libro V. Domenici - A. Buonauro, All women want love. Il desiderio femminile e la decostruzione del romance nel cinema di Jane Campion (Armando Editore, Roma 2015), che esplora l’autorialità della cineasta neozelandese da una prospettiva culturalista e di genere, e alla luce di recenti studi postcoloniali e psicoanalitici sul cinema e la spettatorialità.
C'è un’articolata riflessione sul rapporto dell’opera di Campion con la letteratura. Osservazioni tanto più significative se si considera che la corporeità femminile occupa un ruolo centrale nei suoi film, e viene esibita col gusto di una trasgressione mai scomposta e fine a se stessa (come nelle nudità di Sweetie e nelle donne di Paradise in Top of the Lake), e con la predilezione per certi dettagli fisici (piedi, mani, occhi, capelli), mostrati per frammenti e spesso ripresi in primo piano e ingigantiti come «installazioni minimaliste».
Autrice antipodean, non solo geograficamente, di vere e proprie ordalie esistenziali, Campion descrive i rapporti tra donne e uomini nella società patriarcale con uno sguardo antropologico e una costante attenzione agli aspetti formali della narrazione cinematografica. Le sue storie raccontano della scoperta delle passioni e della sessualità come di una vera e propria iniziazione alla vita; e la loro ambientazione, non di rado fatta di scenari naturali, diventa palcoscenico di un ancestrale rito di passaggio, di cui le donne sono, al contempo, sacerdotesse e iniziande.
La Weltanschauung della cineasta neozelandese sperimenta dunque un linguaggio alternativo e trasgressivo, capace di esprimere la profonda e mai scontata rivolta alle regole che è propria delle sue protagoniste. Di questa visione e della complessità dello stile che ne deriva, perfettamente armonico rispetto ai significati veicolati, le pagine di questo libro intendono restituire la ricchezza, l’originalità, l’impegno a esplorare la diversità, sia sul piano tematico sia su quello formale. Nella convinzione che l’opera di Campion sia innervata nell’attualità e costituisca una sorta di diario del cammino che la donna occidentale ha percorso, dal Romanticismo a oggi, e una messa a fuoco di grande importanza sui motivi delle lotte che le donne, in ogni parte del mondo, devono ancora sostenere per vedere riconosciuti i loro diritti.
Con i loro comportamenti anticonvenzionali e il temperamento volitivo, le sue protagoniste cercano la propria identità sotto la spinta di un’intima inquietudine: dall’entropica Sweetie (Sweetie) alla talentuosa Janet Frame (Un angelo alla mia tavola), dalle ribelli nomadiche Ada (Lezioni di piano) e Ruth (Holy Smoke -Fuoco sacro), alle tenaci Isabel (Ritratto di signora), Frannie (In the Cut), Fanny (Bright Star) e Robin (Top of the Lake). Ed è per questo che uno dei temi ricorrenti di queste opere è il viaggio: l’itineranza fisica e interiore delle sue donne serve a scandagliare le zone più buie e sotterranee della loro personalità, un’esplorazione condotta all’insegna di una prospettiva anti-ideologica che delinea un immaginario femminile ribelle e autenticamente “altro”:
«Sono una donna e mi sembra perfettamente naturale la scelta di personaggi femminili. Voglio capire il più possibile la loro vita. Di conseguenza mi chiedo come vivono le altre donne, e di cosa è fatta la loro esistenza. Credo sia il motivo per cui i registi raccontano storie di uomini. Non riesco a immaginare di raccontare la storia di un uomo, e non so perché dovrei farlo. Sono certamente curiosa del loro mondo, ma preferisco stare al centro del mio universo. Lo stesso vale per le storie d’amore, per le quali non scelgo una prospettiva maschile».
https://www.cinematografo.it/recensioni/il-potere-del-cane/
D’altra parte, le sue eroine condividono una condizione di sradicamento e di esilio emozionale, sintomatica della loro vocazione nomadico-esperienziale e di una relazione olistica con la vita. La “lucida follia” che le accomuna sprigiona un’eversiva forza vitalistica e rende questo cinema “non riconciliato”, anzitutto perché le protagoniste, nel contesto della tradizione occidentale, sperimentano in prima persona le proprie contraddizioni e ambiguità.
La cineasta osserva le dinamiche di potere tra uomini e donne come un’entomologa, e con questo approccio scevro di pregiudizi esplora le forme del patriarcato, aprendo orizzonti per lo scardinamento dei ruoli e dei rapporti di forza precostituiti: anche gli uomini infatti sono sospinti verso il cambiamento, mostrando, dall’interno delle asimmetrie relazionali tra i sessi, come la propria egemonia non sia immune da vulnerabilità e paure. Ed è per questo che l’universo femminile della regista neozelandese si propone «non come opzione rispetto al maschile, ma come nuovo immaginario da costruire».
«Una delle cose che abbiamo imparato dai film diretti dagli uomini – spiega Campion – è come sia la “donna dei sogni”. La cosa che abbiamo imparato dai film girati dalle donne è come sono le donne reali. Non penso che gli uomini vedano le cose in maniera sbagliata e le donne in maniera corretta, solo vediamo le cose in maniera diversa».
In ciò risiede la qualità umanistica dei suoi film, esercitata grazie a uno sguardo che indaga le profondità dell’animo umano, le ambiguità e fragilità dei personaggi, come pure la loro determinazione e capacità di resistenza. Così, l’occhio antropologico della regista ci coinvolge nella sua “osservazione partecipante” degli esseri umani e degli accadimenti inscenati, esaltando gli elementi primigeni (il fuoco in Holy Smoke o l’acqua in Lezioni di piano e in Top of the Lake) e il tumulto esistenziale e dei sentimenti. Alla radice di questa predilezione troviamo l’impulso autoriflessivo di questo cinema, che saggia il proprio stile prendendo in carico in modo originale l’espressione di sensazioni e accadimenti ambigui o rimossi, di cui Campion ci dà continui esempi: dai disegni e dalle accelerazioni che manifestano l’immaginario di Kelly in Le due amiche alla proliferazione arborea che angoscia Kay in Sweetie, dalla féerie notturna di Un angelo alla mia tavola alle “visioni” indiane di Ruth in Holy Smoke e ai tagli dei pattini sulla neve di In the Cut, fino alle nuvole sul terreno inaridito di The Water Diary e agli ornamenti di ossa in Top of the Lake.
Ne emerge la tempra di una cineasta che promuove un linguaggio cinematografico antiretorico, fondato su una sofisticata direzione delle/degli interpreti. Una pratica di regia che fa della sceneggiatura un work in progress e del set l’happening di un’appassionata avventura autoriale.